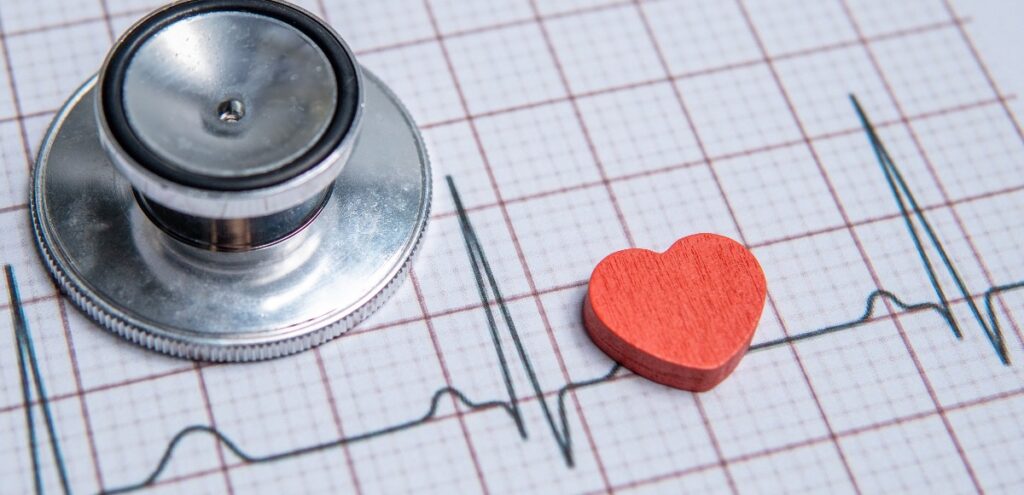Celiachia: come accorgersi di averla
La celiachia è una malattia autoimmune cronica dell’intestino tenue scatenata dall’ingestione di glutine in soggetti geneticamente predisposti.
Questa patologia colpisce circa l’1% della popolazione mondiale e può manifestarsi a qualsiasi età, dall’infanzia all’età adulta. Il riconoscimento precoce dei sintomi è fondamentale per evitare complicanze a lungo termine e migliorare significativamente la qualità della vita.
Celiachia cos’è: definizione e meccanismo
La celiachia è una condizione in cui il sistema immunitario reagisce in modo anomalo al glutine, una proteina presente in cereali come frumento, orzo, segale e farro. Quando una persona celiaca consuma alimenti contenenti glutine, il sistema immunitario attacca erroneamente i villi intestinali, le piccole proiezioni che rivestono l’intestino tenue e permettono l’assorbimento dei nutrienti.
Questo processo autoimmune porta a un’infiammazione cronica che danneggia progressivamente la mucosa intestinale, causando l’appiattimento dei villi. La superficie assorbente dell’intestino si riduce drasticamente, compromettendo l’assorbimento di nutrienti essenziali come vitamine, minerali, carboidrati, proteine e grassi.
La celiachia non è un’allergia alimentare né un’intolleranza, ma una vera e propria malattia autoimmune con base genetica. Per sviluppare la celiachia è necessaria una predisposizione genetica specifica, ma non tutti i portatori dei geni di suscettibilità sviluppano la malattia, suggerendo l’importanza di fattori ambientali scatenanti.
Come accorgersi di essere celiaco: i primi segnali
I sintomi della celiachia possono essere molto variabili e spesso aspecifici, il che rende la diagnosi particolarmente complessa. I primi segnali possono essere subdoli e svilupparsi gradualmente nel tempo, portando spesso a diagnosi tardive. È importante prestare attenzione a sintomi che persistono nel tempo e non trovano spiegazione in altre condizioni.
I disturbi gastrointestinali sono spesso i primi a manifestarsi, ma non sono sempre presenti. Molte persone celiache presentano invece sintomi extraintestinali che possono far pensare ad altre patologie. La variabilità dei sintomi dipende dall’età di insorgenza, dall’estensione del danno intestinale e dalla durata dell’esposizione al glutine.
È fondamentale considerare la celiachia quando si presenta una combinazione di sintomi apparentemente scollegati, specialmente se accompagnati da carenze nutrizionali inspiegabili o da una storia familiare positiva per malattie autoimmuni. La presenza di altri disturbi autoimmuni nello stesso individuo dovrebbe sempre far sospettare la celiachia.
Quali sono i sintomi di chi è celiaca
I sintomi intestinali classici della celiachia includono dolori addominali ricorrenti, gonfiore, diarrea cronica, stitichezza, meteorismo e crampi. Le feci possono essere maleodoranti, voluminose e oleose a causa del malassorbimento dei grassi. Tuttavia, è importante sottolineare che molti celiaci non presentano sintomi gastrointestinali evidenti.
I sintomi extraintestinali sono molto comuni e possono includere anemia da carenza di ferro resistente al trattamento, perdita di peso inspiegabile, stanchezza cronica, irritabilità, depressione e difficoltà di concentrazione. Nei bambini si può osservare ritardo della crescita, ritardo dello sviluppo puberale e difetti dello smalto dentario.
Altri sintomi frequenti comprendono dolori articolari, crampi muscolari, formicolii agli arti, mal di testa ricorrenti, eruzioni cutanee come la dermatite erpetiforme, afte ricorrenti del cavo orale e irregolarità mestruali nelle donne. La presenza di osteoporosi precoce o fratture da fragilità può essere un segnale di celiachia non diagnosticata.
Celiachia cause: fattori scatenanti e predisposizione
La celiachia ha una forte componente genetica: circa il 95% dei celiaci presenta l’aplotipo HLA-DQ2, mentre la maggior parte dei rimanenti presenta HLA-DQ8. Tuttavia, questi geni sono presenti anche nel 30-40% della popolazione generale, ma solo l’1% sviluppa la celiachia, indicando che la predisposizione genetica è necessaria ma non sufficiente.
I fattori ambientali scatenanti includono infezioni virali, stress fisico o emotivo, gravidanza, interventi chirurgici e l’introduzione precoce o tardiva del glutine nella dieta del bambino. Alcune ricerche suggeriscono che infezioni da rotavirus o adenovirus possano innescare la celiachia in soggetti predisposti attraverso un meccanismo di mimetismo molecolare.
L’età di introduzione del glutine nella dieta infantile sembra influenzare il rischio di sviluppare celiachia. Sia l’introduzione molto precoce (prima dei 4 mesi) che quella tardiva (dopo i 7 mesi) potrebbero aumentare il rischio. L’allattamento al seno sembra avere un effetto protettivo, probabilmente ritardando l’insorgenza della malattia.
Celiachia sintomi: manifestazioni per età
Nei neonati e bambini piccoli, la celiachia si manifesta tipicamente con sintomi gastrointestinali evidenti: diarrea cronica, vomito, addome gonfio, irritabilità e mancata crescita. I bambini possono presentare anche ipotrofia muscolare, particolarmente evidente a livello dei glutei, e ritardo nello sviluppo psicomotorio.
Negli adolescenti i sintomi sono spesso più subdoli e possono includere bassa statura, ritardo puberale, anemia, dolori addominali ricorrenti e problemi comportamentali. Molti adolescenti celiaci presentano solo sintomi extraintestinali, rendendo la diagnosi particolarmente difficile in questa fascia d’età.
Negli adulti la celiachia può manifestarsi con una varietà di sintomi spesso aspecifici. Oltre ai disturbi gastrointestinali, sono comuni astenia, irritabilità, depressione, artralgie, osteoporosi, infertilità e aborti ricorrenti. In alcuni casi la celiachia può rimanere completamente asintomatica e venire diagnosticata solo attraverso screening in soggetti a rischio.
Celiachia diagnosi: gli esami necessari
La diagnosi di celiachia si basa su un approccio multistep che include anamnesi, esami del sangue, biopsia intestinale e risposta alla dieta senza glutine. È fondamentale che tutti gli esami vengano eseguiti mentre il paziente segue ancora una dieta contenente glutine, poiché l’eliminazione del glutine può portare a falsi negativi.
Gli esami del sangue ricercano anticorpi specifici: anti-transglutaminasi tissutale (tTG), anti-endomisio (EMA) e anti-gliadina deaminata (DGP). Gli anticorpi anti-transglutaminasi di classe IgA sono il test di screening di prima scelta, ma è importante dosare anche le IgA totali per escludere un deficit selettivo di IgA.
La biopsia duodenale rimane il gold standard per la diagnosi di celiachia nell’adulto. L’esame istologico valuta il grado di atrofia dei villi secondo la classificazione di Marsh, che va da 0 (normale) a 3c (atrofia completa). In alcuni casi selezionati, specialmente nei bambini con titoli anticorpali molto elevati, la diagnosi può essere posta senza biopsia.
Quali sono i cibi che una persona celiaca non può mangiare
I celiaci devono eliminare completamente dalla dieta tutti gli alimenti contenenti glutine. I cereali vietati includono frumento, farro, kamut, orzo, segale, avena non certificata gluten-free, triticale e tutti i loro derivati. Questo significa evitare pane, pasta, pizza, biscotti, torte e molti prodotti da forno tradizionali.
Particolare attenzione deve essere prestata ai prodotti industriali, dove il glutine può essere presente come addensante, stabilizzante o aromatizzante. Salse, sughi pronti, insaccati, alcuni formaggi, birra, malto e molti prodotti confezionati possono contenere glutine. È essenziale leggere sempre le etichette e cercare la dicitura “senza glutine”.
La contaminazione crociata rappresenta un rischio significativo per i celiaci. Anche quantità minime di glutine possono scatenare la reazione autoimmune. È importante utilizzare utensili, stoviglie e superfici dedicate, evitare oli di frittura condivisi e prestare attenzione durante la preparazione dei pasti in cucine non dedicate.
Che cosa non deve mangiare un celiaco: lista dettagliata
Oltre ai cereali contenenti glutine, i celiaci devono fare attenzione a molti altri alimenti. La birra tradizionale è vietata perché prodotta con orzo maltato, così come il malto e tutti i suoi derivati. Alcuni insaccati possono contenere glutine come legante, quindi è necessario verificare sempre la composizione.
Molti condimenti e salse preparate industrialmente contengono glutine: salsa di soia tradizionale, alcune salse Worcester, molti dadi da brodo, alcune spezie preparate e aromi artificiali. Anche alcuni farmaci e integratori possono contenere glutine negli eccipienti, quindi è importante consultare sempre il medico o il farmacista.
I prodotti dell’industria dolciaria sono spesso a rischio: caramelle, cioccolato con cereali, gelati con biscotti o coni, chewing-gum e molti dolci confezionati. È fondamentale scegliere sempre prodotti certificati senza glutine o verificare attentamente le etichette per assicurarsi dell’assenza di ingredienti vietati.
La dieta senza glutine: principi e benefici
L’unico trattamento efficace per la celiachia è l’adozione di una dieta rigorosamente senza glutine per tutta la vita. Questa dieta deve essere seguita scrupolosamente, poiché anche piccole quantità di glutine possono mantenere l’infiammazione intestinale e impedire la guarigione dei villi.
I cereali permessi includono riso, mais, miglio, quinoa, amaranto, grano saraceno, teff e sorgo. Questi cereali naturalmente privi di glutine possono essere utilizzati per preparare pasta, pane e altri prodotti da forno. È importante verificare che siano certificati gluten-free per evitare contaminazioni durante la lavorazione.
La dieta senza glutine, se seguita correttamente, porta a un miglioramento dei sintomi nell’arco di settimane o mesi e alla guarigione istologica dell’intestino entro 1-2 anni. È importante essere seguiti da un dietista esperto per assicurare un’alimentazione equilibrata e prevenire carenze nutrizionali, particolarmente di fibre, vitamine del gruppo B e minerali.
Complicanze della celiachia non trattata
La celiachia non diagnosticata o non trattata può portare a gravi complicanze a lungo termine. Il malassorbimento cronico può causare carenze nutrizionali severe con anemia, osteoporosi, disturbi della coagulazione e deficit vitaminici. Nei bambini si osservano ritardi di crescita e sviluppo che possono essere irreversibili se non trattati tempestivamente.
Le complicanze più gravi includono un aumentato rischio di sviluppare altre malattie autoimmuni come diabete tipo 1, tiroidite autoimmune, epatite autoimmune e malattie del tessuto connettivo. Esiste anche un rischio aumentato di sviluppare tumori del tratto gastrointestinale, in particolare linfomi intestinali.
La celiachia refrattaria rappresenta una complicanza rara ma grave, caratterizzata dalla persistenza dell’atrofia villare nonostante una dieta senza glutine rigorosa per almeno 12 mesi. Questa condizione richiede un trattamento immunosoppressivo specifico e un monitoraggio stretto per il rischio di evoluzione neoplastica.