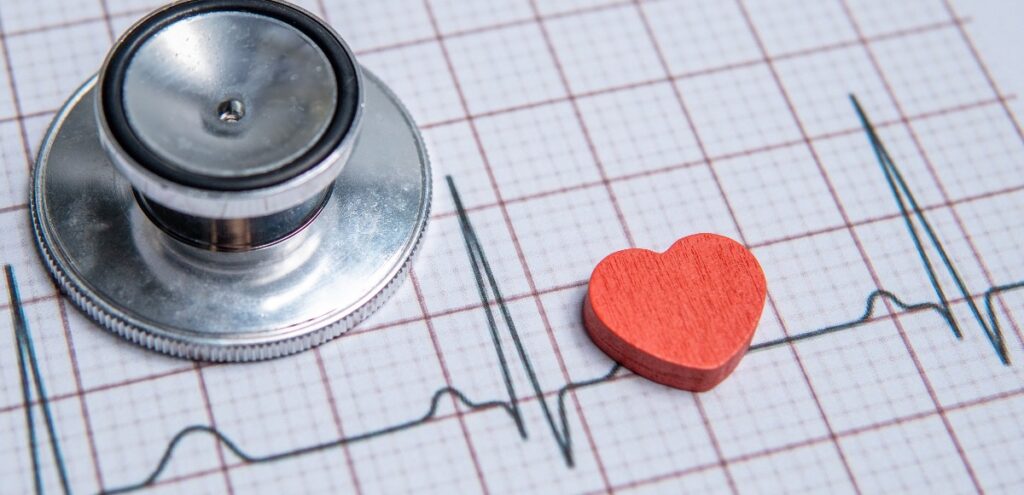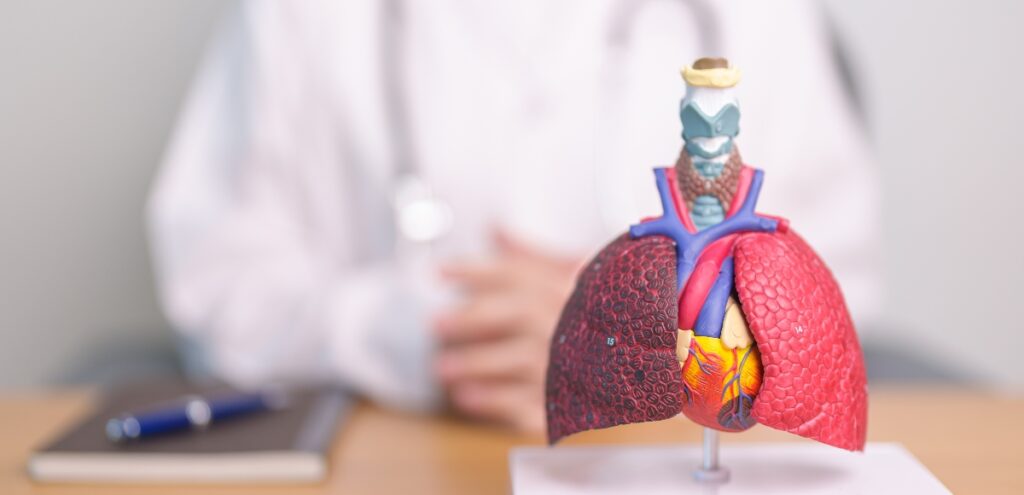
La fibrosi cistica: cos’è e quali sintomi presenta
La fibrosi cistica è una malattia genetica ereditaria che colpisce principalmente i polmoni e l’apparato digerente, causando la produzione di secrezioni mucose dense e appiccicose.
Si tratta di una delle malattie genetiche più comuni nelle popolazioni di origine europea, con un’incidenza di circa 1 caso ogni 2.500-3.000 nati. Nonostante sia una condizione cronica e progressiva, i progressi nella diagnosi e nel trattamento hanno significativamente migliorato la qualità e l’aspettativa di vita dei pazienti.
Che cos’è la fibrosi cistica
La fibrosi cistica (FC), nota anche come mucoviscidosi, è causata da mutazioni nel gene CFTR (Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator), che codifica per una proteina fondamentale nel trasporto di cloro attraverso le membrane cellulari. Quando questa proteina non funziona correttamente, si verifica un’alterazione dell’equilibrio idrico ed elettrolitico che porta alla produzione di secrezioni mucose anormalmente dense.
Queste secrezioni dense si accumulano nei dotti e nei condotti di vari organi, causando ostruzioni e infiammazioni croniche. Gli organi più colpiti sono i polmoni, il pancreas, il fegato, l’intestino e gli organi riproduttivi.
La fibrosi cistica è una malattia autosomica recessiva, il che significa che per manifestarsi è necessario ereditare una copia del gene mutato da entrambi i genitori. I portatori sani (con una sola copia del gene mutato) non sviluppano la malattia ma possono trasmetterla alla prole.
Come si eredita la fibrosi cistica
La fibrosi cistica si trasmette seguendo le leggi dell’ereditarietà mendeliana:
- Se entrambi i genitori sono portatori sani, ogni figlio ha il 25% di probabilità di essere affetto, il 50% di essere portatore sano e il 25% di essere completamente sano
- Se uno dei genitori è affetto e l’altro è sano, tutti i figli saranno portatori sani
- Se uno dei genitori è affetto e l’altro è portatore, ogni figlio ha il 50% di probabilità di essere affetto e il 50% di essere portatore
Sono state identificate oltre 2.000 mutazioni diverse del gene CFTR, ma la più comune (circa il 70% dei casi) è la mutazione ΔF508, che causa la perdita dell’amminoacido fenilalanina nella posizione 508 della proteina.
Sintomi della fibrosi cistica
I sintomi della fibrosi cistica possono variare notevolmente da persona a persona, anche all’interno della stessa famiglia. La gravità dipende dal tipo di mutazioni presenti e da fattori ambientali e genetici modificatori.
Sintomi respiratori
I polmoni sono spesso l’organo più colpito nella fibrosi cistica:
- Tosse persistente: inizialmente secca, poi produttiva con espettorato denso e purulento
- Respiro sibilante: dovuto all’ostruzione delle vie aeree
- Dispnea (difficoltà respiratoria): progressiva, inizialmente solo sotto sforzo
- Infezioni respiratorie ricorrenti: bronchiti, polmoniti, sinusiti
- Congestione nasale cronica: con polipi nasali frequenti
- Deformità toracica: torace a botte dovuto all’iperinsufflazione polmonare
Sintomi gastrointestinali
L’apparato digerente è frequentemente coinvolto:
- Ileo da meconio: ostruzione intestinale nel neonato (presente nel 15-20% dei casi)
- Malassorbimento: dovuto all’insufficienza pancreatica esocrina
- Feci voluminose, maleodoranti e oleose (steatorrea): per malassorbimento dei grassi
- Ritardo della crescita: peso e altezza inferiori alla norma
- Carenze vitaminiche: soprattutto vitamine liposolubili (A, D, E, K)
- Dolori addominali ricorrenti: dovuti a ostruzioni intestinali parziali
- Prolasso rettale: soprattutto nei bambini piccoli
Sintomi metabolici
- Disidratazione: perdita eccessiva di sale attraverso il sudore
- Sapore salato della pelle: caratteristico della malattia
- Crampi muscolari: dovuti alla perdita di elettroliti
- Alcalosi metabolica: alterazione dell’equilibrio acido-base
Sintomi negli adulti
Con l’età, possono svilupparsi complicazioni aggiuntive:
- Diabete correlato alla fibrosi cistica (CFRD): dovuto al danno pancreatico
- Malattia epatica: cirrosi biliare focale
- Osteoporosi: per malassorbimento di calcio e vitamina D
- Artropatie: dolori articolari e artrite
- Infertilità: soprattutto negli uomini per agenesia dei dotti deferenti
Fibrosi cistica nel neonato
La diagnosi precoce è fondamentale per migliorare la prognosi. Nel neonato, i segni che possono suggerire fibrosi cistica includono:
- Ileo da meconio: presente nei primi giorni di vita, richiede intervento chirurgico
- Ritardo nell’evacuazione del meconio: oltre le 48 ore dalla nascita
- Sapore salato della pelle: uno dei primi segni che i genitori possono notare
- Difficoltà nell’allattamento: per problemi respiratori o gastrointestinali
- Scarso incremento ponderale: nonostante un apporto nutrizionale adeguato
- Episodi di disidratazione: soprattutto nei periodi caldi
In molti paesi, inclusa l’Italia, è attivo lo screening neonatale per la fibrosi cistica attraverso il dosaggio della tripsina immunoreattiva (IRT) nel sangue del neonato.
Aspettativa di vita e prognosi
L’aspettativa di vita per le persone con fibrosi cistica è significativamente migliorata negli ultimi decenni:
- Negli anni ’50, la maggior parte dei bambini non sopravviveva oltre l’infanzia
- Attualmente, l’aspettativa di vita mediana è di circa 40-45 anni nei paesi sviluppati
- Molti pazienti raggiungono l’età adulta e possono avere una vita relativamente normale
I fattori che influenzano la prognosi includono:
- Precocità della diagnosi: diagnosi e trattamento precoci migliorano significativamente l’outcome
- Tipo di mutazioni: alcune mutazioni causano forme più lievi
- Aderenza alle terapie: il rispetto del piano terapeutico è cruciale
- Accesso alle cure specialistiche: centri di cura specializzati migliorano gli outcome
- Fattori ambientali: esposizione al fumo, inquinamento, infezioni
Come si manifesta la fibrosi cistica a 70 anni
Mentre tradizionalmente la fibrosi cistica era considerata una malattia dell’infanzia e dell’adolescenza, oggi sempre più pazienti raggiungono l’età adulta avanzata. A 70 anni, le manifestazioni possono includere:
- Insufficienza respiratoria cronica: necessità di ossigenoterapia domiciliare
- Bronchiectasie severe: dilatazioni permanenti dei bronchi
- Cuore polmonare: insufficienza cardiaca destra secondaria alla malattia polmonare
- Diabete di lunga durata: con possibili complicanze vascolari
- Malattia epatica avanzata: con possibile necessità di trapianto
- Osteoporosi severa: con aumentato rischio di fratture
- Neoplasie: possibile aumentato rischio di alcuni tumori
Diagnosi della fibrosi cistica
La diagnosi si basa su diversi approcci:
Test del sudore
È il test diagnostico gold standard:
- Misura la concentrazione di cloro nel sudore
- Valori >60 mEq/L sono diagnostici per fibrosi cistica
- Valori tra 30-60 mEq/L sono borderline e richiedono ulteriori indagini
- Valori <30 mEq/L sono normali
Test genetico
- Identifica le mutazioni del gene CFTR
- Importante per la consulenza genetica
- Può identificare portatori sani
Screening neonatale
- Dosaggio della tripsina immunoreattiva (IRT)
- Se elevata, si procede con test del sudore o genetico
- Permette diagnosi precoce e inizio tempestivo delle terapie
Altri test diagnostici
- Funzionalità pancreatica: dosaggio di elastasi fecale
- Colture dell’espettorato: per identificare batteri patogeni
- Funzionalità polmonare: spirometria per valutare la capacità respiratoria
- Imaging: radiografia e TC del torace per valutare il danno polmonare
Trattamento della fibrosi cistica
Il trattamento è multidisciplinare e mira a:
Gestione delle secrezioni respiratorie
- Fisioterapia respiratoria: drenaggio posturale, percussioni toraciche
- Farmaci mucolitici: come la dornasi alfa per fluidificare il muco
- Soluzione salina ipertonica: per migliorare l’idratazione delle secrezioni
- Broncodilatatori: per aprire le vie aeree
Trattamento delle infezioni
- Antibiotici: per via orale, endovenosa o inalatoria
- Trattamento delle infezioni croniche: soprattutto da Pseudomonas aeruginosa
- Profilassi antibiotica: in alcuni casi per prevenire infezioni
Supporto nutrizionale
- Enzimi pancreatici: per rimpiazzare quelli non prodotti dal pancreas
- Supplementi vitaminici: soprattutto vitamine liposolubili
- Dieta ipercalorica e iperproteica: per compensare il malassorbimento
- Supplementi di sale: per compensare le perdite attraverso il sudore
Terapie innovative
- Modulatori del CFTR: farmaci come ivacaftor, lumacaftor, tezacaftor che migliorano la funzione della proteina CFTR
- Terapia genica: ancora in fase sperimentale
- Trapianto polmonare: nei casi di insufficienza respiratoria terminale
Prevenzione e counseling genetico
La prevenzione primaria si basa sul counseling genetico:
- Test di screening per portatori: raccomandato per coppie a rischio
- Diagnosi prenatale: amniocentesi o villocentesi in gravidanze a rischio
- Consulenza genetica: per valutare i rischi riproduttivi
La fibrosi cistica rimane una malattia impegnativa, ma i continui progressi nella comprensione della patologia e nello sviluppo di nuove terapie offrono speranze sempre maggiori per migliorare la qualità e la durata della vita dei pazienti.